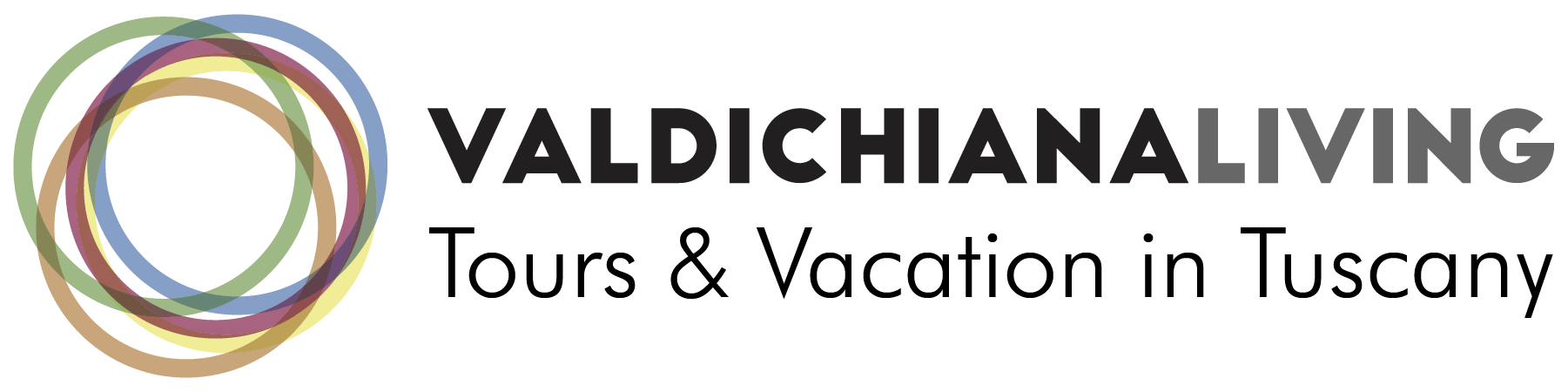PerBacco
Un viaggio alla scoperta di oggetti legati al consumo del vino dall’Epoca Etrusca al Seicento
Visitare il Museo Civico di Montepulciano può rivelarsi un’esperienza particolarmente significativa per chi raggiunge questa città per degustare e apprezzare il vino Nobile: un momento di incontro tra la cultura del consumatore e il luogo dove si conservano gli oggetti e le iconografie che definiscono l’identità culturale di questo territorio di produzione vitivinicola.
L’esperienza si pone il fine di avvicinare il pubblico alla cultura millenaria del vino locale, per comprendere il valore immateriale delle tradizioni locali e la specificità del paesaggio antropizzato.
La degustazione in cantina associata alla visita del museo, conducono a un livello di maggiore soddisfazione del consumatore, in grado di apprezzare oltre alle qualità olfattive e gustative della bevanda, la storicità e le implicazioni socio culturali che nei secoli hanno concorso a formare la cultura del bere.
CONSUMO DEL VINO IN EPOCA ETRUSCA (Spazi a piano terra)
Nell’antichità i prodotti come i cereali e le verdure si collocavano nello spazio del necessario e del quotidiano, il vino al contrario si consumava insieme alla carne sulle tavole dei ricchi, ed era una bevanda riservata a momenti e a ospiti importanti. Il vino infatti era un marcatore di status sociale, perché separava la condizione dei ricchi da quella dei poveri. Ed è proprio nei corredi tombali Etruschi di alto livello sociale che si trovano i corredi potori (insieme di recipienti utilizzati per contenere e bere il vino) di maggior pregio.
La tomba infatti diveniva la casa del defunto per l’eternità e dunque vi si raccoglievano gli oggetti di pregio funzionali alle attività come il vasellame di ceramica o metallo che serviva per il simposio: un aristocratico momento d’incontro nel quale si consumava vino, con l’accompagnamento di musiche e danze.
Prima di essere filtrato e consumato, il vino veniva diluito con acqua e aromatizzato con miele, petali di rosa o viola e, talvolta, con l’aggiunta di formaggio grattugiato.
Nelle vetrine della sezione archeologica sono numerose le testimonianze ceramiche legate al consumo del vino. Tutte rinvenute nelle tombe della necropoli di Acquaviva, nel territorio di Montepulciano, risalgono almeno al secondo quarto del VI sec. a. C., cioè all’inizio del cosiddetto periodo arcaico.
1.1 Anfora in bucchero decorata a stampo, utilizzata per il trasporto del vino
1.8 Kyathos miniaturistico in bucchero, utilizzato per attingere la bevanda dalle olle o dai crateri
1.11 Patera ombelicata in bronzo, utilizzata per bere il vino
2.2 Oinochoe in bucchero, utilizzato per versare il vino ai convitati
4.1 Anfora in ceramica attica a figure nere, utilizzata per il trasporto del vino
4.2 Hydria di bucchero, contenitore per l’acqua
4.4 Olla biansata, utilizzata durante il simposio miscelare il vino e l’acqua



In Epoca Etrusca il consumo del vino si svolgeva secondo un cerimoniale ben definito di cui ci danno utili indicazioni i coperchi delle urne cinerarie ellenistiche che troviamo proseguendo nel museo.
Sui coperchi appunto, sono presenti sia figure maschili sia femminili adagiati sui klinai (letti) e distesi su un fianco, con un braccio poggiato sui cuscini mentre con la mano del braccio libero tengono la patera o la kylix: i contenitori per bere. Questa era la posizione che gli etruschi assumevano durante il simposio: un rito sociale di lusso, una aggregazione tra aristocratici che si ispirava al mondo greco-orientale. Uomini e donne distesi sui letti conversavano o cantavano accompagnati da musici e danzatrici, erano inoltre presenti i servitori che versano il vino. Il simposio era un rito collettivo e come tale assumeva anche un significato religioso: ogni simposio si apriva con una invocazione agli dei e ad essi era dedicato il primo brindisi, l’unico che poteva essere fatto con il vino puro. Seguivano altri brindisi alla salute dell’uno o dell’altro partecipante al simposio.
La coltivazione e la produzione del vino dagli Etruschi veniva affidata alla protezione del dio Fufluns, l’equivalente del greco Dioniso che si credeva avesse donato il vino all’umanità: un vino che se bevuto in quantità controllate permetteva un’estasi rivelatrice di realtà nascoste, se assunto smodatamente travolgeva la coscienza e rendeva folli. Quindi il vino era il mezzo per accedere a una conoscenza più acuta e il simposio diveniva il culmine culturale dell’incontro della società aristocratica.
Ciò che differenzia la convivialità etrusca da quella greca e da quella romana è la presenza della donna che partecipava al simposio e beveva il vino alla pari dell’uomo.
Oltre ai dadi e ai giochi da tavolo, nei simposi si praticava il gioco del kottabos che consisteva nel lanciare da una kylix un fiotto di vino verso un oggetto di bronzo costituito da un’alta asta munita di un disco alla sommità. Anche il tiro come il brindisi, era dedicato a una persona e quando il bersaglio veniva colpito, il vincitore riceveva in premio dolci, leccornie, uova o baci.
5.7 Kyathos miniaturistico in bucchero, utilizzato per attingere la bevanda dalle olle o dai crateri
5.9 Infundibulum in bucchero, utilizzato per filtrare la bevanda
6.1 Kylix attica a figure rosse, utilizzata per bere il vino
6.2 Cratere a colonnette etrusco con figure rosse sovraddipinte, utilizzato durante il simposio per miscelare il vino e l’acqua
6.20 Oinochoe in bronzo, utilizzato per versare il vino ai convitati



Tra le varie rappresentazioni di questo gioco ne riproduciamo una presente su una kylix a figure rosse, oggi al Museo Archeologico di Firenze ma proveniente da una tomba scavata agli inizi del Novecento nel territorio di Montepulciano.
La scena di gioco raffigura Fufluns, dio etrusco, con barba e capelli lunghi che, un po’ ubriaco, si appoggia a un satiro. Fufluns si appresta a lanciare il vino da una kylix guardando intensamente una menade adorna di gioielli e coperta in parte da un ampio mantello. La donna sta poggiando sulla sommità del kottabos un piattello tondo che, per la riuscita del gioco, l’ultimo sorso di vino dovrà colpire e far cadere sul bacile sottostante provocando un caratteristico rumore. Nell’attimo del lancio si esclamava anche il nome della persona a cui si richiedeva l’intrattenimento erotico. Fufluns era divinità agreste ma anche erotica, che attraverso il vino consumato in sontuosi banchetti permetteva alle classi elevate dell’Etruria l’esibizione del loro status e della loro ricchezza, prima nelle loro abitazioni e successivamente nelle loro tombe dove la coppa di vino suggellava un brindisi eterno.
CONSUMO DEL VINO NEL MEDIOEVO (Piano seminterrato)
La vite e il vino sono stati un principio di identificazione per la civiltà mediterranea, greco-latina prima e poi cristiana rispetto ai popoli barbari che producevano e consumavano la birra.
Furono proprio i monaci a diffondere nell’Europa centro-settentrionale la coltivazione della vite. In questo modo la civiltà del vino si diffuse attraverso il cristianesimo e la vite e il vino assunsero un altissimo valore simbolico: la vigna identificava la comunità dei fedeli e quindi la chiesa stessa e il vino il sangue di Gesù.
La produzione, l’uso e la commercializzazione del vino sono stati aspetti molto importanti di tutte le civiltà antiche del Mediterraneo che consideravano il consumo del vino non solo come alimento ma anche come atto rituale, per di più nell’antichità era distintivo di una certa classe sociale. Si trattava di un bene prezioso che acquisiva un ruolo determinante nell’atto sacrale, e tale ha continuato ad avere in tutte le civiltà antiche, come pure nella liturgia cattolica della celebrazione della Messa.
Nell’Italia medievale il vino era di gran lunga la bevanda più prodotta e consumata.
La viticoltura a Montepulciano è attestata per la prima volta in un documento che risale al 798 e alla metà del Trecento la città emanò norme per regolarne il commercio e l’esportazione. Presente nelle tavole di tutte le categorie sociali, il vino era venduto al minuto un po’ dovunque: negli alberghi, nelle taverne, ma anche nei mercati, nelle botteghe di artigiani, in strada e perfino in casa di privati. Raramente di qualità eccelse, il vino presentava una vasta tipologia: dai rossi, ai bianchi, agli amabili. Oltre che bevuto liscio, il vino veniva insaporito con spezie, aromi o frutta, era considerato una bevanda prelibata spesso presente nei pranzi speciali e nei banchetti. Particolarmente apprezzate erano le sue proprietà terapeutiche. Comunemente utilizzato nella preparazione di numerosi farmaci, il suo contenuto di alcool lo impose come diffuso antisettico capace di combattere il diffondersi di epidemie che invece nell’acqua trovavano un facile veicolo di propagazione.
1 Mesciroba in maiolica arcaica decorata con pavoni, utilizzato per versare i liquidi
3 Boccale in maiolica arcaica decorato con motivo vegetale, utilizzato per versare il vino
24 Frammenti di recipienti in vetro tra i quali fondi di bicchiere, utilizzati per bere il vino


LA COLTIVAZIONE DELLA VITE (Primo piano, sala poliziana)
Al primo piano del museo, nella sala poliziana, è possibile osservare una grande Veduta di Montepulciano, databile negli anni Trenta del Seicento che documenta la coltivazione della vite sul crinale del colle dove sorge la città. La campagna è disseminata di case coloniche dove avveniva la pigiatura dell’uva e la fermentazione del vino. Come appare evidente da questa fedele veduta, la vite ha rappresentato una coltivazione di straordinaria importanza per questo territorio, ne ha caratterizzato il paesaggio, ne ha determinato l’economia e la sua conservazione ha dato continuità alla tradizione.
Attraverso l’archeologia e l’iconografia artistica da un lato e la lettura del paesaggio agrario dall’altro, è possibile ricostruire le dinamiche evolutive di questo territorio. Con molta probabilità già nella preistoria era presente la vite selvatica, detta anche “vite maritata” perché cresciuta su piante vive.
Con il tempo questo tipo di coltivazione e stata soppiantata dall’usanza di far crescere la pianta su sostegni “morti” (pali e paletti). Questa pratica già introdotta dai greci, si è poi diffusa fino a divenire in epoca moderna prevalente.

Pittore toscano della prima metà del Seicento
Veduta della città di Montepulciano da sud est
IL CONSUMO DEL VINO IN ETÀ MODERNA (Piano secondo)
Entrando nel salone del secondo piano, subito a destra, si può apprezzare il calice dipinto in primo piano sulla tavola della Cena in Emmaus. Benché la tela sia stata realizzata nella prima metà del Seicento, l’uso del bicchiere a calice è documentato anche in opere del secolo precedente
Altre opere esposte in questo salone mostrano contenitori del Seicento utilizzati per il vino, come ad esempio la brocca in ceramica a forma di utello presente nel dipinto del pittore neerlandese vicino a Eberrhard Keilhau detto Monsù Bernardo (a sinistra dell’ingresso) con la quale una donna versa il vino in una ciotola.
Lo stesso oggetto si trova nel vicino dipinto raffigurante l’Interno di cucina di Carlo Antonio Crespi. Qui è presente anche una bottiglia in vetro con la quale spesso il vino veniva servito nelle tavole di elevati contesti sociali. L’acqua invece veniva servita con la brocca in vetro, se ne può osservare una nella bellissima natura morta di Cristoforo Munari subito a destra.
Francesco Canini (?)
(Sinalunga?, notizie dal 1616 al 1643)
Cena in Emmaus
dipinto con particolare del calice in vetro

Maniera di Eberhard Keilhau detto Monsù Bernardo
(Helsingor, 1624 - Roma 1687)
Donna con brocca
dipinto con particolare della brocca in ceramica

Carlo Antonio Crespi
(Bologna, 1712-1782)
Interno di cucina
dipinto con particolare della brocca in ceramica e della bottiglia per il vino in vetro

Cristoforo Munari
(Reggio Emilia, 1667 – Pisa, 1720)
Brocca di vetro, strumenti musicali, libri, spartito musicale, foglio di lettera, tazzine in porcellana, nastro
dipinto con particolare della brocca in vetro per l’acqua